Pensiamo ad una bevanda famosa, registrata col medesimo marchio e così venduta in molti Paesi, distribuita con la medesima confezione e immagine. Pensiamo, ad esempio, a Italia e Germania. Effettivamente, il consumatore tedesco potrebbe percepire, tra la bottiglia tedesca che acquista abitualmente nel supermercato sotto casa e quella italiana acquistata durante la sua vacanza sulle nostre spiagge alcune differenze nelle rispettive caratteristiche o composizione. La bevanda della stessa marca (stesso marchio, stessa confezione) ma acquistata in Paesi diversi, può risultare diversa agli occhi e al gusto del consumatore medio, di fatto determinando una disparità tra consumatori dell’uno o dell’altro Paese, soprattutto se dovesse risultare che il consumatore tedesco non avrebbe acquistato quella bottiglia in Italia se avesse saputo che aveva qualità differenti rispetto a quella da lui solitamente acquistata in Germania.

Fino a quando le scelte strategiche dell’impresa, l’adeguamento alle diverse richieste del mercato, le particolarità nella fabbricazione a seconda del clima e delle diversità del luogo possono prevalere sulla legittima aspettativa del consumatore medio nei confronti di un prodotto di marca noto per le sue qualità e caratteristiche di composizione? Fino a quando tali differenze di qualità[1] sono legittime e non inducono in errore il consumatore? Quando, invece, sono contrarie alla normativa europea e costituiscono ipotesi di pratiche commerciali sleali?
Con COMUNICAZIONE DEL 29.09.2017[2], la Commissione europea ha pubblicato alcune considerazioni e piani di azione per aiutare le competenti Autorità degli Stati membri verso una corretta e comune applicazione delle norme, ha delineato alcuni criteri per l’individuazione di casi di differenze di qualità illegittime e ingiustificate, e suggerito conseguenti strategie contro le pratiche commerciali sleali ai danni del consumatore sulla base dei principi generali sanciti dal Reg. CE n.178/2002, le norme del Reg. UE n.1169/2011 sulle informazioni ai consumatori di alimenti, e la Dir. 2005/29/CE[3] sulle pratiche commerciali sleali.
Dopo aver evidenziato alcuni importanti aspetti contenuti nelle norme sopra ricordate, la Commissione ritiene necessario rafforzare alcuni punti per capire se effettivamente una certa pratica commerciale sia da considerare sleale e per adottare le misure opportune a tutela del consumatore, prospettando 4 AZIONI di intervento e strategia: 1.finanziamento e promozione di progetti nazionali di studio e ricerca per migliorare il rispetto della normativa di settore; 2.sviluppo di una metodologia di prova comune e armonizzata tra gli Stati, da parte del Centro comune di ricerca (JRC); 3.collaborazione e dialogo tra la Commissione, produttori e venditori al dettaglio, attraverso forum, riunioni e discussioni mirate; 4.orientamenti per le Autorità nazionali, con indicazioni operative per attuare la normativa e rafforzare i controlli e il contrasto alle pratiche sleali.

Secondo gli orientamenti della Commissione, per poter valutare se una pratica commerciale sia in contrasto con la Direttiva occorre procedere con una valutazione caso per caso con cui dimostrare che: i consumatori, che hanno in mente un “prodotto di riferimento[4]”, riponevano alcune aspettative nel prodotto che hanno acquistato, che invece di discosta in maniera significativa; le informazioni sul prodotto fornite dal professionista ai consumatori non sono adeguate per consentire di comprendere che vi potrebbero essere delle differenze rispetto alle loro aspettative; le informazioni inadeguate o insufficienti sono tali da incidere in misura determinante sul comportamento economico del consumatore, inducendolo ad acquistare un prodotto che altrimenti non avrebbe acquistato.
La Commissione evidenzia poi alcuni elementi oggettivi in presenza dei quali si può riscontrare una differenza significativa delle caratteristiche principali di un prodotto. Ciò accade quando, ad esempio, un ingrediente essenziale, una serie di ingredienti essenziali, o una sua percentuale differiscono in maniera sostanziale dal prodotto di riferimento, e quando la differenza potenzialmente in grado di incidere sul comportamento economico del consumatore, che avrebbe assunto una diversa scelta d’acquisto se avesse saputo tale differenza.
Inoltre, la Commissione sta lavorando per riuscire a definire una metodologia scientifica solida e condivisa per l’acquisizione e gestione delle prove comparative sui prodotti, sta finanziando attività di sviluppo per rafforzare il rispetto della normativa e sta promuovendo occasioni di dialogo con i soggetti della filiera interessati, produttori, consumatori, autorità e controllori.
[1] Per differenze di qualità di alcuni prodotti si intende, appunto, il caso in cui prodotti commercializzati nell’ambito del mercato unico sotto lo stesso marchio o denominazione commerciale presentano, negli Stati membri, differenze in termini di composizione o qualità.
[2] Trattasi della Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti – il caso specifico dei prodotti alimentari, (2017/C 327/01).
[3] Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.05.2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/7/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento CE n.2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
[4] Secondo i criteri di individuazione proposti dalla Commissione, il prodotto di riferimento, che funge da termine di paragone tra quanto ci si aspetta e quanto concretamente si ottiene dal prodotto acquistato, è un prodotto venduto in diversi Stati membri con lo stesso marchio e lo stesso imballaggio, è venduto nella maggior parte degli Stati membri con una determinata composizione, la percezione delle principali caratteristiche da parte dei consumatori corrisponde alla composizione del prodotto come pubblicizzata nella maggior parte degli Stati membri.
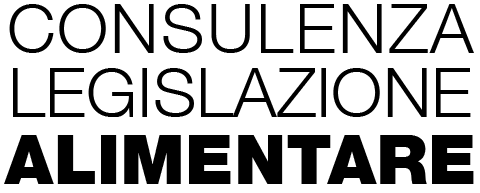

 Il Reg. UE n.1169/2011 detta poi specifiche disposizioni relative all’etichettatura, prevedendo all’art.21 che le sostanze in questione devono figurare nell’elenco ingredienti in ordine ponderale decrescente, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto presente nell’all.II, che va evidenziata con un carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti. In mancanza di un elenco ingredienti le indicazioni utilizzano il termine “contiene” seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto, e quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici provengono da un’unica sostanza o prodotto presente nell’all.II, tale circostanza deve essere precisata per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico.
Il Reg. UE n.1169/2011 detta poi specifiche disposizioni relative all’etichettatura, prevedendo all’art.21 che le sostanze in questione devono figurare nell’elenco ingredienti in ordine ponderale decrescente, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto presente nell’all.II, che va evidenziata con un carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti. In mancanza di un elenco ingredienti le indicazioni utilizzano il termine “contiene” seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto, e quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici provengono da un’unica sostanza o prodotto presente nell’all.II, tale circostanza deve essere precisata per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico.










 È interessante, poi, il richiamo espresso agli obblighi di tracciabilità a carico degli operatori, tra i vari adempimenti specifici a cui sono tenuti dall’art.4 che prevede “Gli operatori sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilita’ di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilita’ dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La tracciabilita’ deve essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. La relativa documentazione giustificativa deve essere fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali”.
È interessante, poi, il richiamo espresso agli obblighi di tracciabilità a carico degli operatori, tra i vari adempimenti specifici a cui sono tenuti dall’art.4 che prevede “Gli operatori sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilita’ di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilita’ dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La tracciabilita’ deve essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. La relativa documentazione giustificativa deve essere fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali”. 
 Vi sono anche delle eccezioni ammesse dalla Decisione 2010/791/UE
Vi sono anche delle eccezioni ammesse dalla Decisione 2010/791/UE La Corte ha dunque stabilito che l’art. 78, par. 2 e l’All.VII, parte III del Reg. UE n.1308/2013 “devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all’allegato I della decisione 2010/791/UE”.
La Corte ha dunque stabilito che l’art. 78, par. 2 e l’All.VII, parte III del Reg. UE n.1308/2013 “devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all’allegato I della decisione 2010/791/UE”. Poco più di un anno fa, ricordiamo, è entrata in vigore la Legge n. 166/2016
Poco più di un anno fa, ricordiamo, è entrata in vigore la Legge n. 166/2016 